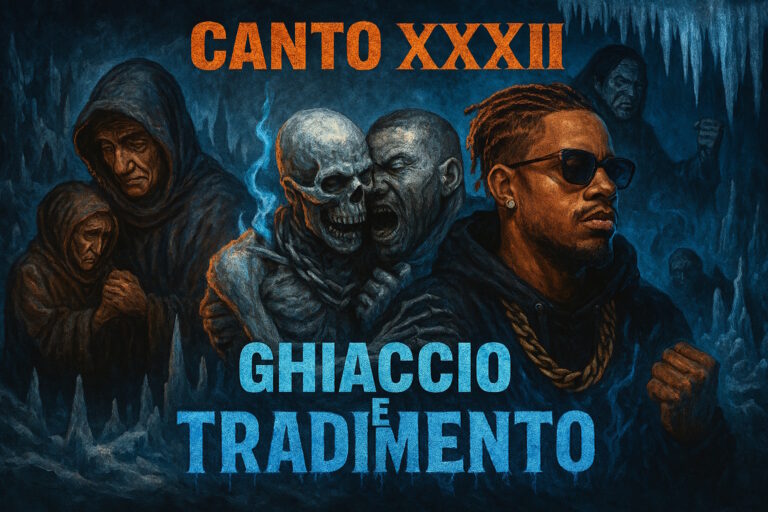In un tempo in cui l’Italia non era ancora una nazione, ma un sogno che prendeva forma tra i cuori e le battaglie dei suoi figli, nacquero parole e gesti che avrebbero segnato la nostra identità.
Tra queste parole, risuona ancora oggi la voce di Luigi Mercantini, poeta del Risorgimento, capace di dare voce al sentimento di un popolo che stava nascendo.
Nel 1858 scrisse “La spigolatrice di Sapri”, una poesia semplice e potente, capace di trasformare la storia in leggenda.
A parlare è una spigolatrice, una giovane contadina che raccoglieva le spighe rimaste nei campi dopo il raccolto. Con occhi innocenti e cuore sincero, diventa testimone di un evento destinato a entrare nella memoria collettiva: lo sbarco di Carlo Pisacane e dei suoi trecento patrioti sulle coste di Sapri, in Campania, nel tentativo di sollevare il popolo contro la tirannide borbonica.
Il racconto della spigolatrice non è solo una cronaca: è uno sguardo commosso e partecipe, che trasforma una sconfitta militare in un atto di eroismo, un sacrificio che accende il sentimento nazionale e la speranza di un’Italia unita e libera.
Mercantini fu anche autore del celebre “Inno a Garibaldi” (dalla quale ho tratto la cover omonima che ho pubblicato su questo blog), che accompagnò i volontari nelle battaglie per l’indipendenza e divenne uno dei simboli più forti del Risorgimento.
La sua poesia, sempre intrisa di passione e di ideali, seppe unire popolo e patrioti in un unico canto di libertà.
Oggi ho voluto ridare suono e passo a quei versi, trasformandoli in una marcia patriottica: un inno alla memoria, alla speranza, e a quel desiderio di patria che, più di un secolo e mezzo fa, ardeva nei cuori di chi credeva in un destino comune.
Un viaggio musicale nella nostra storia, per ricordare che l’identità nasce dal sacrificio, dal coraggio e dalla passione.
La spigolatrice di Sapri (1858 – Luigi Mercantini)
Eran trecento, eran giovani e forti,
e sono morti!
Me ne andava al mattino a spigolare
quando ho visto una barca in mezzo al mare:
era una barca che andava a vapore,
e alzava una bandiera tricolore.
All’isola di Ponza si è fermata,
è stata un poco e poi si è ritornata;
s’è ritornata ed è venuta a terra;
sceser con l’armi, e a noi non fecer guerra.
Eran trecento, eran giovani e forti,
e sono morti!
Sceser con l’armi e a noi non fecer guerra,
ma s’inchinaron per baciar la terra.
Ad uno ad uno li guardai nel viso:
tutti aveano una lagrima e un sorriso.
Li disser ladri usciti dalle tane,
ma non portaron via nemmeno un pane;
e li sentii mandare un solo grido:
“Siam venuti a morir pel nostro lido”.
Eran trecento, eran giovani e forti,
e sono morti!
Con gli occhi azzurri e coi capelli d’oro
un giovin camminava innanzi a loro.
Mi feci ardita, e, presol per la mano,
gli chiesi: “Dove vai, bel capitano?”
Guardommi, e mi rispose: “O mia sorella,
Vado a morir per la mia patria bella”.
Io mi sentii tremare tutto il core,
né potei dirgli: “V’aiuti il Signore!”
Eran trecento, eran giovani e forti,
e sono morti!
Quel giorno mi scordai di spigolare,
e dietro a loro mi misi ad andare:
due volte si scontrâr con li gendarmi,
e l’una e l’altra li spogliâr dell’armi:
ma quando fûr della Certosa ai muri,
s’udirono a suonar trombe e tamburi;
e tra ’l fumo e gli spari e le scintille
piombaron loro addosso più di mille.
Eran trecento, eran giovani e forti,
e sono morti!
Eran trecento e non voller fuggire,
parean tre mila e vollero morire;
ma vollero morir col ferro in mano,
e avanti a loro correa sangue il piano:
fin che pugnar vid’io per lor pregai,
ma a un tratto venni men, né più guardai:
io non vedea più fra mezzo a loro
quegli occhi azzurri e quei capelli d’oro.
Eran trecento, eran giovani e forti,
e sono morti!